Lo scrittore americano Jonathan Safran Foer invita a non cedere all’indifferenza. A Genova, in occasione del conferimento del Premio internazionale Primo Levi ha tenuto un discorso incentrato sui concetti di memoria, responsabilità e indifferenza. Citando il dramma di Gaza ha invitato i presenti a mantenere alta la vigilanza morale di fronte alla sofferenza del mondo, a non considerare le difficoltà un ostacolo bensì un punto di partenza e a trasformare i problemi in uno stimolo a ritrovare la forza etica e soprattutto a non trasformarsi in ombre…

*
Buonasera,
sono qui davanti a voi questa sera non solo onorato, ma anche turbato. Turbato dalla responsabilità che deriva dall’invocare il nome di Primo Levi. È giusto che sia così. Levi non ha scritto per confortarci. Non ha scritto per intrattenerci o redimerci. Ha scritto per turbarci. Credeva, come diceva lui stesso, che «è successo, quindi può succedere di nuovo»; ciò che può succedere non è il cataclisma della Shoah, ma l’indifferenza che ha permesso che accadesse. C’è una domanda alla base di tutta la sua opera: restare svegli. Non solo vigili nei confronti della storia, ma vulnerabili al presente.
Levi non mirava a scioccare, ma a turbare. Il suo turbamento non era estetico o psicologico, era morale. Aveva lo scopo di mantenerci in una sorta di inquietudine sospesa. Non era solo un sopravvissuto che raccontava una catastrofe morale, ma un pensatore ebreo, profondamente radicato in una tradizione che diffida dell’agio e guarda con sospetto l’anima serena.
L’ebraismo ha sempre posto il disagio al centro del risveglio morale. Ad Abramo, il patriarca del monoteismo, viene comandato di non rimanere dove si trova, ma di “andare avanti” – lech lecha – un doppio comando di lasciare il luogo fisico e di allontanarsi da sé stessi, dal proprio comfort, dalla stasi. Mosè non diventa profeta in virtù della sua discendenza o della sua intelligenza, ma perché si ferma a notare la violenza contro uno schiavo. La sua grandezza inizia con l’attenzione, il turbamento.
I profeti della Torah sono figure profondamente turbate. Camminano per le loro città gridando contro l’ingiustizia, le loro parole sono come sirene contro l’autocompiacimento di chi vive nell’agiatezza. Non sono venerati dai loro contemporanei, anzi vengono derisi, esiliati, ignorati. Eppure, nella coscienza ebraica, sono la coscienza del popolo. Coloro che non permettono che la sofferenza diventi normalità. Nelle parole del profeta Amos: «Guai a coloro che vivono nell’agio». Non perché l’agio sia intrinsecamente sbagliato, ma perché genera dimenticanza. I profeti ci turbano perché la dimenticanza è il seme della crudeltà.
Essere turbati, nell’immaginario morale ebraico, non è una debolezza. È una forma di forza. È ciò che Dio loda in Giobbe: il suo rifiuto di accettare in silenzio le ingiustizie. Giobbe discute con Dio. Abramo discute con Dio. Mosè discute con Dio. Il tratto distintivo dell’esempio morale ebraico è la protesta. E non la protesta come rumore, ma la protesta come empatia, come rifiuto di accettare un mondo in cui la vita umana non viene venerata.
In ebraico, la parola che significa compassione, rachamim, ha la stessa radice di rechem, che significa grembo materno. La compassione nell’ebraismo non è sentimentalismo. Non è pietà. È feroce, incarnata, generativa. Nasce da dentro di noi, come il travaglio. Ha un prezzo. E ci trasforma. Il Talmud insegna che chiunque non sia turbato dalla sofferenza degli altri è sospetto, non solo come cittadino, ma come essere umano. Come ha scritto il rabbino Abraham Joshua Heschel, “Il contrario del bene non è il male, è l’indifferenza”.
Il turbamento di Levi non era performativo. Non era autocelebrativo. Era faticoso.Era uno scienziato e uno scrittore, e ha usato gli strumenti di entrambe le professioni per illuminare i meccanismi della disumanizzazione: il linguaggio, i sistemi e i silenzi. Ci ha mostrato non solo cosa è successo ad Auschwitz, ma come è successo, come questa mancanza di reazione potrebbe succedere ovunque.
E così stasera voglio parlare non solo di Levi, ma di questa tradizione più profonda su cui ha lavorato. Una tradizione che dice: essere umani significa essere turbati.

Due settimane fa, il mondo ha perso Papa Francesco, un uomo la cui leadership spirituale era straordinaria non perché offriva conforto, ma perché offriva disagio con grazia. Ci ha ripetutamente messo in guardia da quella che definiva la “globalizzazione dell’indifferenza”. Non riesco a pensare a una descrizione più appropriata e potente dei nostri tempi. L’indifferenza globalizzata non è passiva. È progettata. È integrata nelle nostre economie, nelle nostre tecnologie, nei nostri cicli mediatici. È il software che funziona silenziosamente sullo sfondo della vita quotidiana, gettando ombre su ciò che vediamo, ciò che proviamo e su chi consideriamo umano.
Diamo un’occhiata al mondo in cui viviamo.
A Gaza sono stati uccisi più di 30.000 civili, molti bruciati nelle loro case, i loro nomi mai registrati, le loro vite a mala pena compiante. È una presa d’atto, un’emergenza che diventa politica. Gli esseri umani non sono statistiche. Sono bambini che cercano le braccia delle madri, madri che cercano di proteggere i propri figli.
Dopo un anno e mezzo, ci sono ostaggi israeliani ancora nei tunnel, molti dei loro nomi dimenticati dai titoli dei giornali, il loro destino non menzionato nelle conversazioni quotidiane. La loro prigionia è uno specchio del nostro distacco. Ogni giorno che passa senza che vengano salvati è un giorno che mette alla prova la profondità della nostra empatia.
In Sudan, ci sono quasi nove milioni di sfollati per la guerra, la carestia e il collasso politico. Le città bruciano, i villaggi scompaiono. Eppure, per la maggior parte di noi, il Sudan rimane un nome su una cartina, geografica, un luogo che non sappiamo dove si trovi, e che forse non proviamo neppure a cercare.
In Ucraina, una guerra che un tempo ha sconvolto la coscienza dell’Occidente non fa più notizia. Ogni giorno muoiono civili. Gli ospedali vengono bombardati. I bambini dormono nelle cantine. Abbiamo imparato a scorrere lo sguardo sugli schermi oltre la loro sofferenza, a tenere gli occhi e la bocca chiusi. Ma, come ben sapeva Levi, il silenzio non è assenza. È complicità.
E mentre ci aggiorniamo in silenzio sulle notizie dai cellulari, 45 milioni di bambini sotto i cinque anni soffrono di malnutrizione, la forma più letale di denutrizione. Corrisponde quasi alla popolazione della Spagna. Fermiamoci un attimo a immaginare la Spagna popolata esclusivamente da bambini che muoiono di fame di età inferiore ai cinque anni. Proviamo a immaginarli mentre camminano come zombie lungo Le Ramblas, seduti per terra dentro Reina Sofia, o che affollano ristoranti senza cibo…
Undici bambini muoiono di fame ogni minuto. Fermatevi un attimo a riflettere. Mi è stato detto che questo discorso non deve superare i trenta minuti. In questo lasso di tempo, 330 bambini moriranno di fame. In questa sala ci sono circa 330 persone. Immaginate quindi che tutti i posti siano occupati da bambini. Immaginate che il vostro posto sia occupato da un bambino. E immaginate che alla fine di questo discorso, tutti questi bambini saranno morti. Non di siccità. Non per la scarsità di cibo. Ma per le disuguaglianze deliberate e progettate dai nostri sistemi globali. Perché noi, le persone che stanno effettivamente in questo salone ora abbiamo deciso che va bene così.
Quasi un miliardo di persone va a letto affamato ogni sera. Immaginate l’intera popolazione di Genova che va a letto affamata. Ogni nonno e ogni nonna. Ogni bambino. Ogni neonato. Ora immaginate che questo accada ogni singola sera. Ora immaginate 2.000 città affamate grandi come Genova. Questa è la nostra situazione attuale. Quando è stata l’ultima volta che avete avuto fame? Una fame perenne? Per me, e immagino per tutti i presenti in questa sala, la fame è un concetto astratto. Ma per chi ha bisogno di mangiare, non è qualcosa di astratto. È un bambino che piange ed esausto si addormenta. È una madre che finge di aver già mangiato lasciare al figlio l’ultimo cucchiaio di riso.
Non è solo una vergogna, non è solo una tragedia. È un’eresia, un tradimento del sacro principio secondo cui tutti gli esseri umani hanno dignità.
Primo Levi aveva compreso qualcosa di essenziale: l’atrocità non inizia con la brutalità. Inizia con l’indifferenza. Inizia con burocrazie silenziose e amministratori impassibili, con quelli che Levi definiva “i funzionari pronti a credere e ad agire senza farsi domande”.
Gli scritti di Levi hanno posto l’essere umano, e non il fatto storico, al centro dell’evento. Non ci ha fornito dati, ma consistenza. E quella consistenza, fatta di fame, umiliazione, memoria, è inquietante non solo per ciò che rivela, ma anche per come resiste alla risoluzione. La sua testimonianza non è un capitolo chiuso. È una ferita aperta.
Il pericolo più grande oggi non è una minaccia esterna, ma il fatto che non siamo più sufficientemente inorriditi.
Diciamo: “È terribile” e andiamo avanti. Diciamo: “Non ce la faccio più”, come se fosse un peso per noi e non la morte del figlio di qualcun altro.
Eppure, il turbamento non è disperazione. Essere turbati non significa essere paralizzati. Significa essere vivi. Significa avere a cuore qualcosa, spesso in modo scomodo, spesso doloroso. Il turbamento è la risposta immunitaria dell’anima.
Nel Talmud c’è un insegnamento: “Se qualcuno può protestare per i peccati della propria famiglia e non lo fa,è responsabile per i peccati della propria famiglia;se qualcuno può protestare per i peccati della propria città, e non lo fa,è responsabile per i peccati della propria città;se qualcuno può protestare per i peccati del mondo e non lo fa,è responsabile dei peccati del mondo”. Il silenzio, in questa tradizione, è colpevolezza.
Nei suoi ultimi sermoni pubblici, Papa Francesco ha insistito sul fatto che la nostra speranza risiede in quella che ha definito una “cultura dell’incontro”. Non la carità a distanza, non la pietà da uno schermo, ma l’incontro. Come ha affermato: “Dobbiamo aprire il nostro cuore a coloro che sono scartati e riconoscerli non come un peso, ma come uno specchio”.
Questa non è poesia. È strategia.
Non combattiamo l’indifferenza con le statistiche. La combattiamo con i volti, con i nomi, con le storie. Questo è il ruolo della letteratura: non distrarci, ma disarmarci. Farci sentire più di quanto sia comodo. Riumanizzare ciò che il mondo ha reso anonimo, gettare luce dove le ombre si sono radicate più profondamente.
Il disagio non è il nostro stato naturale. Deve essere scelto. Coltivato. Protetto. E così spesso sbagliamo. Io sbaglio costantemente. Vedo titoli che non clicco perché non voglio sapere. Ogni giorno della mia vita passo accanto alla sofferenza con una cecità acquisita con l’esperienza. Lascio lì, non letti, appelli urgenti e giusti. Tante volte ho scambiato la compassione per azione, o la rabbia per coraggio.
C’è uno strano conforto nell’indignazione: ci fa sentire svegli, giusti, impegnati. Ma l’indignazione senza azione è solo teatro. E io sono stato così spesso un attore. Quindi non vi parlo stasera da una posizione di chiarezza morale. Sono al vostro fianco come qualcuno che cerca, continuamente, di rimanere turbato. E fallisce. E ci riprova.
La parola “disturbare” deriva dal latino disturbare: dis, che significa “separare”, e turbare, “mettere in disordine, agitare”. Essere disturbati significa essere sbilanciati, strappati dal proprio comfort. Ma l’etimologia ci rivela anche una verità più profonda: se vogliamo creare un cambiamento, dobbiamo prima permettere a noi stessi di essere messi in disordine. Non si può rinnovare il mondo senza essere stati prima disfatti.
Da dove cominciare? La valanga di sofferenza non esiste solo nei titoli dei giornali di paesi lontani. Vive nei nostri quartieri. Si nasconde in bella vista.
Qui a Genova il 15% degli anziani vive in povertà, in silenzio, invisibile, spesso solo. Dietro le finestre chiuse ci sono vite che si spengono lentamente, non per malattia, ma per abbandono. E come chiamiamo una società in cui gli anziani vengono lasciati indietro? La chiamiamo “normale”. E lo diciamo con un’alzata di spalle.
Nelle aule scolastiche di questa regione, quasi un giovane su dieci non sa leggere abbastanza bene da comprendere il testo di questo discorso. Cosa significa questo per il loro futuro? Cosa significa non considerarlo un’emergenza civica? Nel Talmud, il bambino analfabeta non è semplicemente ignorante, è non protetto. Perché l’alfabetizzazione non è solo una competenza, è un’armatura contro l’invisibilità.
La Liguria è una regione ricca di storia, di beni, bellezza. Eppure, cosa ne facciamo di questa eredità? Cosa significa vivere circondati da cattedrali, archivi e piazze di marmo, mentre gli esseri umani che vivono tra noi scompaiono sotto le statistiche economiche e le categorie burocratiche? Anche in questo c’è una sorta di violenza silenziosa, una violenza di cancellazione.
Cosa significherebbe guardare i senzatetto. Non l’archetipo, ma l’individuo. L’uomo che dorme vicino alla stazione ferroviaria avvolto in coperte di recupero. La donna che borbotta tra sé e sé vicino al supermercato, il cui carrello contiene i resti di una vita precedente. Li guardiamo. Ma non li vediamo. E questo guardare senza vedere non è neutro, è corrosivo, per la nostra società e per i nostri cuori.
E che dire del bambino che mangia solo a scuola, per il quale le vacanze estive sono una stagione di fame? Che dire del vicino malato di mente di cui non conosciamo il nome, la cui sofferenza è sopportata dietro porte chiuse, senza parole e senza aiuto? O dell’immigrato le cui qualifiche non vengono mai riconosciute, che guida un taxi invece di esercitare la professione medica? Le loro vite non sono note a piè di pagina nelle nostre vite. Sono testi a sé stanti, testi sacri. E noi li stiamo ignorando.
Primo Levi ci ha chiesto di fermarci a leggerli.
Levi non ha scritto solo di Auschwitz. Ha scritto da dentro Auschwitz e, cosa ancora più importante, da oltre Auschwitz. Le sue parole rifiutano l’astrazione. I suoi dettagli non sono metafore, sono àncore che legano i lettori alla realtà di cui è stato testimone. Un numero tatuato. Un cucchiaio rubato. Una formula chimica recitata per non impazzire.
Nell’ebraismo, ci si avvicina a Dio attraverso l’azione, il rito e la relazione. “Fai e ascolta” –na’aseh v’nishma– è la risposta del popolo nel Sinai. Prima l’azione, poi la comprensione. L’etica precede la teologia.
L’immaginazione etica di Levi appartiene a questa tradizione. La sua scrittura è una forma di testimonianza, non solo dell’orrore, ma della struttura della coscienza. In questo, il suo lavoro riecheggia la filosofia di Emmanuel Levinas, che insegnava che il volto dell’altro è l’inizio di ogni etica. Per Levinas, il volto umano non è una maschera, è una chiamata. Dice, senza usare parole: “Non uccidere”. Ma solo se lo guardiamo.
Martin Buber, un altro pensatore ebreo la cui influenza aleggia sull’opera di Levi, ha scritto della relazione «Io-Tu», quello spazio in cui un essere umano si rivolge completamente a un altro, non come oggetto, ma come presenza. L’etica di Buber non parte dalle leggi, ma dall’incontro. E l’opera di Levi è piena di incontri di questo tipo: il compagno di prigionia che non può dimenticare, la guardia di cui non ha mai saputo il nome, i momenti di inaspettata gentilezza che hanno attraversato la nebbia dell’atrocità. Non sono momenti sentimentali. Sono eventi etici.
Hannah Arendt, anch’essa segnata dai traumi del totalitarismo, sosteneva che il male spesso assume la forma della banalità: non mostri, ma funzionari. Anche Levi lo sapeva. Non ha scritto solo della crudeltà, ma anche dell’ordine. Di persone che seguivano le regole. Che spuntavano caselle. Che non alzavano mai la voce. Eppure il loro silenzio ha facilitato la morte di massa. Questo è ciò che intendeva quando ci avvertiva: è successo, quindi può succedere di nuovo.
Questa riflessione non è pessimismo. È realismo morale. Levi non ci dice di disperarci. Ci chiede di vedere. Di rimanere turbati dai piccoli segni: l’eufemismo, l’alzata di spalle, la stanchezza. Questi sono gli inizi. E ciò che inizia nell’indifferenza finisce nell’annientamento.
La tradizione ebraica ha da tempo considerato la memoria non come un atto passivo di ricordo, ma come una forma di resistenza. La Torah comanda ripetutamente: zachor, ricorda. Ricorda che sei stato schiavo in Egitto. Ricorda cosa ti ha fatto Amalek. Ricorda il sabato. Ricorda lo straniero. Nell’ebraismo, la memoria non è un magazzino dove conserviamo il passato, ma una chiamata ad agire nel presente.
Ricordare significa legarsi alla continuità morale. Significa capire che la storia, per andare avanti, passa attraverso di noi. Noi non siamo la fine della storia, ne siamo il capitolo presente. E ogni atto di dimenticanza è una forma di rottura, non riuscire a portare il peso morale di ciò che è venuto prima.
Ecco perché Levi ha scritto. Ed ecco perché dobbiamo essere lettori, di libri ma anche dei nostri fratelli uomini Leggere Sopravvivere ad Auschwitz non significa piangere i morti, ma leggerne i volti e così facendo, fare della loro memoria una protesta contro il mondo così com’è.
Ma la memoria da sola non basta. È necessaria l’azione. Il Talmud ci dice che in un mondo alla deriva, ogni piccola azione diventa un’ancora. Visitare i malati. Vestire gli ignudi. Istruire gli ignoranti. Non sono opzioni caritatevoli, sono obblighi.
Il nostro compito non è quello di essere eroici. È quello di compiere piccoli gesti di attenzione umana: amare gli anziani anche quando non sono nostri parenti; dare ripetizioni al figlio di qualcun altro; guardare negli occhi la madre rifugiata alla stazione ferroviaria invece di ignorarla; recarsi a un banco alimentare, non perché siamo salvatori, ma perché siamo vicini.
Il concetto di tikkun olam, la riparazione del mondo, non significa aggiustare tutto. Significa rifiutarsi di non aggiustare nulla. Significa capire che ogni atto di gentilezza è una cucitura nel tessuto lacerato del creato. E che anche l’azione più piccola conta.
Sì, il mondo è vasto. Sì, le sue ferite sono profonde. Ma dobbiamo resistere alla paralisi causata dalle dimensioni globali. Dobbiamo scegliere: l’attenzione piuttosto che la distrazione, l’incontro piuttosto che l’evasione, la coscienza piuttosto che il comfort.
Dobbiamo interrompere il meccanismo dell’ingiustizia con la nostra presenza.
Anche solo notare è una forma di protesta. È dire: “Ti vedo. Non sei un’ombra. Non sei rumore. Non sei altro. La tua vita è importante allo stesso modo e nella stessa misura in cui è importante la mia vita”.
Dobbiamo insegnarlo ai nostri figli. Dobbiamo creare riti di commemorazione che non siano solo celebrazioni, ma impegni. Abbiamo bisogno che le nostre festività siano permeate dalla coscienza.
Il popolo ebraico si è sempre definito attraverso la memoria e la presenza: siamo stati schiavi in Egitto e quindi abbiamo marciato a Selma. La nostra è una tradizione di rottura, non di distacco. Eppure, oggi, spesso distogliamo lo sguardo.
Questo deve turbarci. Primo Levi ne sarebbe turbato.
Colui che ha raccontato non solo le atrocità dei campi di concentramento, ma anche il progressivo cedimento della coscienza, sarebbe addolorato dall’isolamento che il benessere comporta. Da come il benessere e la sicurezza degli ebrei in Occidente hanno, in troppi punti, offuscato il nostro impulso profetico. Mentre un tempo eravamo un popolo la cui antenna morale vibrava ad ogni ingiustizia, siamo ora anestetizzati dal nostro stesso successo.
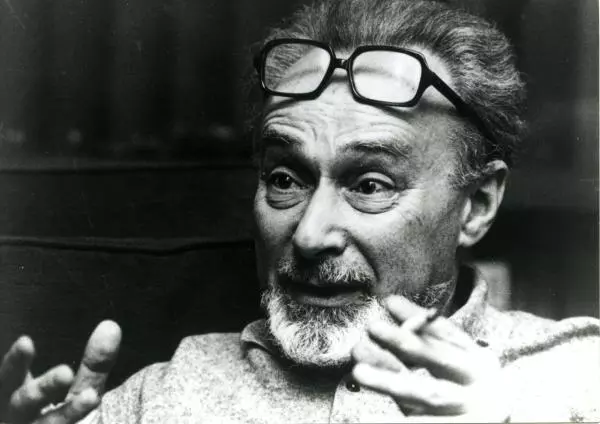
Siamo gli eredi di Abramo, che trattò con Dio per salvare la vita a stranieri; di Mosè, che ruppe le tavole piuttosto che ignorare l’idolatria; di Ester, che rischiò tutto per salvare il suo popolo. E di Levi, che capì che sopravvivere non è sufficiente: bisogna testimoniare.
Cosa penserebbe Levi di una comunità che raccoglie milioni per i musei ma rimane in silenzio mentre i vicini hanno fame? Che racconta la storia della propria schiavitù storica senza reagire con urgenza all’attuale schiavitù di altri? Il cui valore fondamentale è: “Chi salva una vita, salva il mondo intero”, ma nella pratica spesso permette la morte. Non ricordiamo solo la sofferenza ebraica, ma risvegliamone la responsabilità.
Facciamo sì che il piatto del seder non porti solo i simboli del nostro passato, ma anche le domande del nostro presente: chi è schiavo oggi? Chi è invisibile alle nostre porte?
La sinagoga non è mai stata concepita come un rifugio dal mondo. Doveva essere il motore di una compassione radicale. Un luogo non dove il mondo scompare, ma dove viene messo a fuoco con maggiore chiarezza, dove l’ingiustizia non viene ignorata, ma nominata, studiata e affrontata. Dove articoliamo le nostre responsabilità.
Qual ‘ il valore della preghiera che non ci turba né ci cambia?
L’ebraismo che abbiamo creato troppo spesso evita la piazza. Parla a bassa voce a tavola, non alza la voce nei cortei. Benedice i propri figli, ma dimentica gli affamati, i deboli e gli oppressi. Ricorda la sofferenza dei nostri antenati, ma distoglie lo sguardo dalla sofferenza intorno a noi, compresa quella che contribuiamo a infliggere.
Parliamo dei profeti, ma non parliamo come loro.
Un ebraismo che non si dedica ai bisogni del mondo non è affatto ebraismo.
Il Talmud insegna: «La Torah non è stata data in una città, ma nel deserto».
Perché la Torah deve viaggiare. La Torah deve essere portatile. La Torah deve essere portata nel caos.
Il nostro ebraismo troppo spesso teme il caos. Temiamo il rumore della piazza, il dolore dei manifestanti, la rabbia di chi non viene ascoltato. Consideriamo il giudizio un atto di violenza piuttosto che un dono. Sopprimiamo i nostri stessi dubbi.
I profeti non rimanevano in sinagoga. Geremia piangeva tra le rovine. Isaia tuonava dalla piazza. Amos denunciava l’ipocrisia dei riti separati dalla giustizia: «Odio, disprezzo le vostre feste. Che la giustizia scorra come acqua».
Sapevano ciò che dobbiamo ricordare: Dio non si trova solo nell’arca, ma nei volti degli altri del mondo.
Cosa significherebbe quindi trasformare i nostri tempi in motori della coscienza?
Che la sinagoga diventi una base per organizzarsi, non solo un museo della memoria. Che il rabbino sia il primo a combattere il comfort, anziché suo sostenitore. Che il libro di preghiere si apra con: «Di chi sono i bambini che hanno fame? Di chi sono le case perdute? Di chi sono le voci che non sono state ascoltate questa settimana?». Che la Torah sia letta insieme agli avvisi di sfratto e agli elenchi di coloro ai quali è stato negato il voto.
Che il calice del Kiddush sia alzato per brindare non solo al vino, ma a ogni dignità umana riconquistata. Che lo Shabbat sia un momento non solo per riposarsi dal lavoro, ma per dedicarci nuovamente all’opera della compassione.
E non accogliamo solo lo straniero in sinagoga: questo è solo l’inizio del nostro dovere. Usciamo e cerchiamoli nei rifugi e nei tribunali, nei campi profughi e nelle aule scolastiche, e portiamo lì il nostro ebraismo. Non come carità, ma come patto di alleanza.
L’ebraismo deve vivere nel mondo. Perché il mondo sta gridando, e non ci sta chiedendo se abbiamo acceso le candele il venerdì sera. Ci sta chiedendo: Dove eravate quando il bambino aveva bisogno di protezione? Quando il vostro prossimo, non meno meritevole, moriva di fame a pochi passi da casa vostra? Quando il voto è stato rubato? Quando il profugo è stato espulso? Quando il padre ha sollevato in alto il suo bambino morto?
E noi dobbiamo essere in grado di rispondere, non con teorie o difese, ma con tremore e verità: Noi c’eravamo. Il nostro ebraismo ci ha portato lì.
Nessuno di noi deve essere un salvatore, basta essere partecipanti. Testimoni. Vicini. Lettori gli uni degli altri
Levi ci ha ricordato che «gli obiettivi del fascismo non sono stati raggiunti convincendo, ma logorando, trasformando le persone in ombre». Il nostro compito, come lettori e scrittori, come cittadini e vicini, religiosi e non religiosi, come fortunati di essere solo vivi ed abili, è quello di trasformare le ombre in persone: insistere sul colore, sull’individualità, sull’umanità.
Grazie.
(traduzione in italiano di Gabriella Sonnewald)
Jonathan Safran Foer


